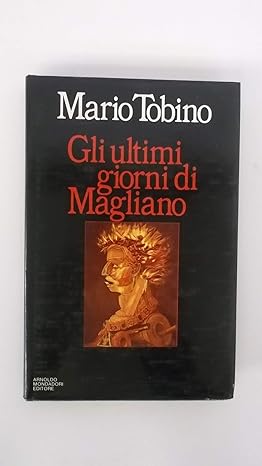La bravura e la dignità letteraria di Tobino si possono notare ad esempio ne “Il perduto amore”, romanzo apparentemente lineare ma in realtà caratterizzato da una prosa cristallina e da grande profondità. Tobino era psichiatra, poeta e scrittore: un uomo versatile e di grande cultura (aveva varie specializzazioni mediche). Come Carlo Bo aveva definito la poesia di Garcia Lorca fatta di “semplicità calcolata”, così, con le dovute proporzioni, potremmo definire la scrittura di Tobino, che ha una notevole resa lirica. Tobino aveva già affrontato il tema della follia ne “Le libere donne di Magliano”, ma ne “Gli ultimi giorni di Magliano” non c’è solo la dimensione sociale e umana dei cosiddetti pazzi ma anche la polemica di quegli anni tra Psichiatria democratica, ovvero la psichiatria sociale, e gli psichiatri come Tobino, che si opponevano alla chiusura dei manicomi. Psichiatria democratica sosteneva che la colpa e la causa della follia erano unicamente della società, e che, come recitava uno slogan in quegli anni, i pazzi erano fuori. Da una parte c’era Basaglia, a cui venne attribuita la frase che “nessuno è normale, visto da vicino”, mentre dall’altra c’erano i tobiniani, che ricordavano che la follia era anche frutto di alterazioni organiche innate. La condizione dei malati di mente per secoli era stata disumana: si veda la storia della follia di Foucault. Ma Tobino, che era un medico della sua epoca, vedeva nel manicomio un luogo non di reclusione ma di protezione: in queste 119 prose sotto forma di annotazioni diaristiche (a tratti poetiche) del libro vengono menzionati anche casi di malati lasciati liberi e che si sono suicidati. Tobino scrive anche che, così facendo, i malati sono lasciati liberi, anche e soprattutto liberi di uccidersi. Da questo punto di vista il manicomio è visto come un’ancora di salvezza e comunque un luogo necessario di cura. Ma c’è anche la dimensione personale e intima dello scrittore, che ha passato quarant’anni a Maggiano (cambiato poi in Magliano), che ha vissuto fianco a fianco con i malati, giorno per giorno, notte per notte. C’è anche il suo senso di sconfitta a causa dei nuovi colleghi che non comprendono e non condividono la sua presa di posizione e lo attaccano personalmente sui giornali e nelle conferenze. Sullo sfondo c’è Lucca: un microcosmo socioeconomico e culturale angusto, dove ci sono pochissimi intellettuali (perché tutti fuggono dalla provincia per trasferirsi nei centri di potere editoriale e salottino di Roma e Milano), dove la vita viene decisa dai pettegolezzi, dal perbenismo, dalla chiusura mentale. Lucca di per sé non era affatto arretrata. Era un feudo democristiano (Lucca è la città delle cento chiese), ma molto industriosa e laboriosa (si pensi che secoli fa i lucchesi battevano moneta da soli). Tobino non ce l’ha visceralmente e idiosincraticamente con Lucca ma accenna al rapporto ontologico tra noia e provincia, che può sfociare nell’invidia, nella gelosia, nella meschineria: Lucca quindi non come natio borgo selvaggio, ma come piccola città (amata e anche criticata) di Guccini. Tobino comunque non era fuggito dalla provincia, più povera di stimoli e di opportunità, ma era rimasto a combattere in trincea quotidianamente. E se oggi si dovesse condannare la presa di posizione a difesa dei manicomi di Tobino, bisogna ricordarsi che gli psicofarmaci esistevano solo dal 1952 (con il Largactil, come lo scrittore ricorda) e non erano ancora efficaci come ai giorni nostri, in cui si trovano persino sul mercato antidepressivi e ansiolitici che sono degli integratori naturali con effetti collaterali rarissimi e che non danno alcuna dipendenza. Chi aveva ragione a distanza di anni e con il senno di poi tra Basaglia e Tobino? Oggi tutti sono concordi nel ritenere che la follia sia un’interazione tra eredità e ambiente, tra natura, società, cultura. Oggi gli psichiatri conoscono più leggi della follia rispetto a un tempo. Oggi esistono strutture sanitarie come il centro di igiene mentale; esistono psicofarmaci molto più efficaci di un tempo. Oggi sappiamo che gli psicofarmaci possono ridurre o addirittura eliminare lo squilibrio neurochimico, ma che, anche se in parte minore, le psicoterapie o terapie della parola possono cambiare la neurochimica dei pazienti e con essa il comportamento e la personalità di base. Oggi con l’arteterapia sappiamo anche che i pazienti possono esprimere il loro vissuto con immagini, simboli, metafore. Si veda inoltre Alda Merini, che ha fornito in poesia la testimonianza umana di una paziente del manicomio. Il ricercatore scientifico e saggista Edoardo Boncinelli ha sostenuto che sono tre cose che decidono la vita delle persone: la genetica, il caos, l’ambiente. Ha aggiunto che se è vero che la genetica e il caos non possono essere modificati, gli esseri umani possono cambiare l’ambiente, inteso in senso lato, quindi anche il contesto sociale e culturale. Comunque la si veda, è innegabile che persone come Tobino ma anche come Basaglia, ognuno a modo loro, abbiano migliorato l’ambiente e con esso la vita dei pazienti psichiatrici. A ogni modo Tobino è stato un grande psichiatra e un grande artista. Schopenhauer scriveva che molti scambiano i limiti della loro visione per i limiti del mondo. Ai tempi dello scrittore viareggino per molti la follia era un altro mondo, anzi per molti il mondo finiva con i sani e i normali. Persone come Tobino hanno allargato gli orizzonti mentali, culturali della loro epoca, considerando i loro pazienti come loro simili (non era affatto scontato a quei tempi): di questo dobbiamo dargliene atto. Tobino quindi deve essere preso di esempio dai giovani psichiatri di oggi per l’umanità, la dedizione, la cultura. Tobino deve insegnare ai giovani psichiatri che per essere psichiatri non ci vogliono solo competenze organiche ma anche empatia, perché il paziente deve essere considerato nella sua dimensione umana e non è solo un caso clinico, e umanesimo, perché il paziente è inserito nella società e nella cultura (i grandi psichiatri, come Andreoli, Borgna, Crepet, sono tutti uomini di scienza e al contempo umanisti).
- Home
- Rubriche
- Appuntamenti
- Amici a quattro zampe
- Più belli con Maria Tona
- L’occhio del ciclone Alfonso Stani
- Credits
- Contatti